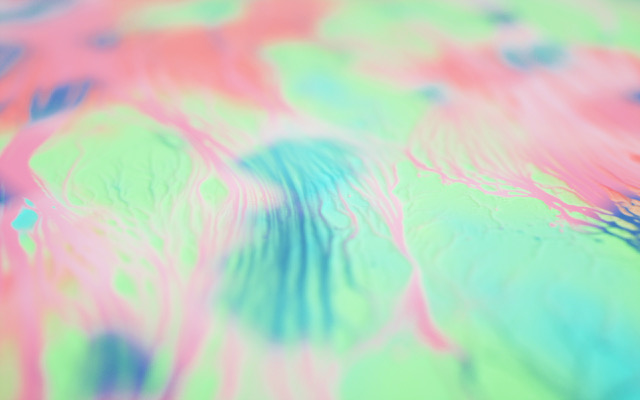Questo saggio considera il contributo dell’ecofemminismo – o femminismo ecologico – al più ampio dibattito attorno alla crisi ecologica e alla crisi del capitalismo, ponendo in campo un ragionamento circa le cause ma anche le alternative praticabili a questo sistema. Oltre a tracciare brevemente la mappa di questo movimento intellettuale e di attivismo, mi concentro su alcuni nodi chiave che caratterizzano l’ecofemminismo: la critica del nesso donna/natura, il materialismo, la questione del sapere, del valore e del lavoro. Cerco anche di evidenziare la relazione tra ecofemminismo ed altre prospettive quali quella decoloniale, antispecista e queer, poiché mi paiono delineare la possibilità di alleanze complesse dentro l’orizzonte trasformativo che si profila in tempo di crisi. La prospettiva ecofemminista dialoga con quella della decrescita nel portare avanti una critica al modello di sviluppo capitalista basato sulla crescita slegata dalla concretezza delle relazioni e dei bisogni sociali ed ecologici, promuovendo pratiche basate sulla logica della ricchezza (vs valore) e della riproduzione (vs produzione).
Il femminismo ecologico nella crisi capitalista – 1
(per una critica del nesso donna/natura)
di Alice Del Gobbo
(pubblicato in Quaderni della Decrescita, settembre-dicembre 2023)
Introduzione
L’ecofemminismo, anche detto femminismo ecologico, è una corrente di pensiero e attivismo che contiene in sé, inseparabilmente, la tensione verso la riflessione sul mondo e quella verso la sua trasformazione. Come il nome stesso suggerisce, le problematiche che si articolano all’interno dell’ecofemminismo nascono dall’intersezione tra riflessione femminista ed ecologista. Tuttavia, non si tratta di una mera sovrapposizione: nel loro incontro, queste entrano in un processo di vero e proprio “divenire”, da cui escono trasformate. Inoltre, sarebbe più corretto parlare di ecofemminismi, dal momento che, come si cercherà di dare conto nel corso di questo saggio, questa cornice concettuale contiene uno spazio composito di posizionamenti politici, intellettuali, pratici tra di loro anche molto divergenti. Essi sono accomunati dall’interesse nell’investigare, decostruire, criticare, e in qualche modo re-istanziare il nesso donna/natura nel contesto della crisi ecologica e del capitalismo più in generale.
Il pensiero ecofemminista dialoga fortemente con quello decrescente per quanto riguarda la critica ai modelli dominanti di sviluppo basati sulla crescita. L’ecofemminismo, infatti, si radica nel punto di vista delle soggettività “minori”, che incarnano delle logiche irriducibili a quelle capitaliste – per quanto ne siano necessariamente implicate. In quanto tali, esse sono portatrici di un senso di esistenza diverso, che mette in discussione forme di dominio, gerarchia e appropriazione tipiche della modernità capitalista, patriarcale e antropocentrica. Come si vedrà, l’ecofemminismo articola un ideale di «sufficienza» (Mellor, 2019) che mette al centro la ricchezza in quanto logica alternativa rispetto a quella del valore e della sua accumulazione (Barca, 2023; Bennholdt-Thomsen 2016). Tuttavia, si è anche evidenziato come la decrescita abbia faticato, negli anni, a mettere in discussione la norma eteropatriarcale e antropocentrica, proponendo a volte addirittura delle visioni stereotipate e in parte reazionarie delle relazioni tra i sessi (Melchiori 2016).
Questo saggio si articola nel modo seguente. Propongo una genealogia del dibattito facendo riferimento a diverse correnti, cercando di focalizzare nel paragrafo successivo una delle questioni principali dell’ecofemminismo: l’articolazione, controversa e dibattuta, del nesso donna/natura. Mi soffermo poi sul tema del materialismo nell’ecofemminismo, evidenziando il modo in cui la costruzione di donna/ natura nella modernità capitalista si intreccia con dinamiche di sapere (e potere), e con la produzione di valore all’interno di catene globali e locali. Le ultime due sezioni fanno un punto rispetto al possibile ruolo che l’ecofemminismo può avere nel contesto delle lotte contemporanee per la giustizia ambientale e climatica, nonché nell’orizzonte della decrescita, sottolineandone il portato intersezionale e anche queer. Concludo infine ragionando su nodi ancora aperti e prospettive di mobilitazione future.
Genealogia, storia e correnti
Il termine «ecofemminismo» viene coniato da Françoise D’Eaubonne (2022) nel suo Le feminisme ou la mort [Il femminismo o la morte] nel 1974, per dar conto di come due lotte che erano state considerate separate fino ad allora, il femminismo e l’ecologismo, stavano trovando un terreno comune non solo di dialogo ma di rivendicazione. La tempistica è interessante poiché coincide con un momento di crisi capitalista in cui si cominciano a intravedere «i limiti della crescita» (il report Limits to Growth del Club di Roma è del 1972) anche in relazione alla crisi petrolifera del 1973. In generale, si tratta di un periodo storico in cui comincia a rendersi particolarmente visibile la contraddizione tra relazioni di produzione e le «forze di riproduzione sociale» (O’Connor, 1988, p. 14).
Ciò ha a che vedere non solo e non semplicemente con dinamiche interne al capitale stesso (per es. i profitti decrescenti derivanti dall’aumento del costo delle materie prime e dalla necessità di riparare il danno ambientale creato dai processi produttivi, si veda a proposito: Gorz, 2015), ma in larga parte anche con le lotte portate avanti sui territori da parte di soggetti che si oppongono allo sviluppo capitalista e alla sua distruzione di ecosistemi e intere forme di vita. Un esempio di movimento inquadrabile nelle lotte ecofemministe in questo periodo è quello Chipko in India, che a partire dal 1973 si organizza per resistere alla messa a valore della foresta da parte di imprese multinazionali, e in cui le donne hanno avuto un ruolo chiave nella messa a punto della strategia e della resistenza.
Anche se il campo ecofemminista si consolida poi attraverso conferenze accademiche, soprattutto negli anni ’80 e ’90, rimane comunque forte il collegamento con le mobilitazioni delle donne per la protezione di corpi e territori (Gaard, 2011). Infatti, è costante il dialogo tra ricerca, attivismo, ma anche pratiche quotidiane nell’ottica di una riconsiderazione delle relazioni socio-ecologiche nel contesto della crisi. Un esempio noto in questo senso è il lavoro di Vandana Shiva (1988), la cui teorizzazione dell’ecofemminismo si lega a doppio filo con le iniziative portate avanti soprattutto nell’ambito del progetto Navdanya International, in cui la difesa dei semi tradizionali che sono stati alla base della sussistenza delle popolazioni indiane è parte di uno sforzo più ampio di ripensamento del rapporto tra gli esseri umani e la Terra.
Uno dei grandi fili conduttori che lega le esperienze che si possono ricondurre all’ecofemminismo si articola attorno al tema dell’identificazione di donna e natura, che vengono svalorizzate e appropriate da parte dell’uomo civilizzato. Questo si lega, come vedremo, a doppio filo con il tema della colonia e dei rapporti imperialistici a livello globale, che plasmano le relazioni tra comunità e territori, tra stati, tra popolazioni. Si inizia a delineare il pensiero secondo cui l’oppressione delle donne e il saccheggio della natura non sono due eventi separati ma intimamente interconnessi, e questa costruzione del nesso donna/natura non può prescindere dai rapporti globali tra «centro» e «periferia» del sistema-mondo capitalista (Bianchi 2016).
Nonostante alcuni assunti comuni di fondo, il campo ecofemminista conosce delle forti divaricazioni, soprattutto in termini teorici. La più significativa è probabilmente quella che Greta Gaard (2017) traccia come la distinzione tra «ecofemminismo culturale» e «ecofemminismo critico». Il primo fa riferimento a quella che si presume essere una reale comunanza tra donne e natura, che le avvicina sul piano esistenziale (e politico), per cui le donne sarebbero intrinsecamente non solo più prossime alla sfera del non umano ma anche le sue “naturali” protettrici. Questo filone sostiene che la secolarizzazione supportata dalla modernità patriarcale rispetto all’esperienza spirituale, incorporata, femminile della natura e dell’esistenza sia uno dei punti cardine che fonda gli assi di dominio che sono alla base delle molteplici crisi che attraversano il sistema capitalista oggi. L’ecofemminismo critico invece rigetta l’idea che esista un’essenza nella donna che la avvicina alla natura; piuttosto, si dice, sono delle strutture socio-culturali ed economiche contingenti che producono questa vicinanza, e ciò deve essere da un lato criticato ma dall’altro riconosciuto come base di una lotta comune per la liberazione dal dominio degli uomini sulle donne e sul resto della natura.
Nonostante un periodo di espansione ed effervescenza teoriche e rivendicative, l’ecofemminismo conosce una fase di “ristagno” che lo mette in secondo piano nelle discussioni intorno all’ecologismo e in generale alle pratiche di trasformazione. L’accusa di essenzialismo è stata sicuramente quella più pesante e che ha fortemente marginalizzato questa corrente di pensiero, soprattutto in un periodo come quello a cavallo del millennio in cui il postmodernismo rigettava qualsiasi categoria che avesse a che vedere con la determinazione materiale dei corpi (Salleh, 2017). È su questo punto che si consuma anche una scissione con la Feminist Political Ecology, che legandosi agli studi sullo sviluppo tende a concentrarsi sul tema delle disuguaglianze a livello locale e globale, e sul modo in cui la vita quotidiana delle donne si intreccia alla crisi ecologica, lasciando in secondo piano temi centrali per l’ecofemminismo come, ad esempio, la soggettività (Rocheleau et al., 1996; Elmhirst 2015).
Si potrebbe anche considerare il fatto che, con l’avvento di parole chiave quali «sviluppo sostenibile» e «crescita verde», una prospettiva che metteva in discussione così radicalmente l’intero impianto del capitalismo patriarcale e antropocentrico non trovasse spazio nell’orizzonte di una nuova compatibilità tra sistema e preservazione della vita. Tuttavia, in un contesto di colossale fallimento di queste politiche che mirano a tingere di verde la crescita capitalista, nonché di una crisi che sempre maggiormente tocca i soggetti fragili quali le donne e le nature non umane (spesso intrecciandole in destini talvolta catastrofici), il pensiero e le pratiche ecofemministe riemergono come degli spazi di lotta, alternativa e cura socio-ecologica.
Il nesso donna/natura tra riproduzione sociale e saperi contestati
La critica ecofemminista si radica nell’orizzonte della crisi per trovarne le cause e al contempo sperimentare delle alternative. Il primo punto che si mette a fuoco – per decostruirlo, ma anche per sottolinearlo – è l’esistenza del nesso donna/natura non soltanto nelle civiltà contemporanee ma per gran parte della storia umana sul pianeta. Secondo la lettura ecofemminista, è la svalutazione o svalorizzazione della donna e della natura ad essere alla base della crisi ecologica e delle molteplici forme di oppressione, dominio, violenza e appropriazione a cui assistiamo (Bianchi 2016). Non si tratta soltanto di capitalismo: come sostiene Ariel Salleh (2017), esso può essere visto come l’articolazione più recente di una lunga storia di patriarcato che ha nei millenni posto le basi per una visione del mondo nichilista, gerarchica, in cui tutti gli aspetti del vivente non riducibili al dominio maschile vengono svalutati per essere controllati e sfruttati.
Senza entrare nel merito delle complesse disamine storiche e storico-politiche che ricostruiscono il passaggio da società egualitarie matriarcali a società gerarchiche patriarcali (si veda tra gli altri Bookchin, 2017), ciò che si può sottolineare è una lunga genealogia che costruisce nel corso dei secoli forme di appropriazione della natura, e del corpo femminile in quanto natura, da parte degli uomini. Si pensi ad esempio allo sviluppo delle scienze e delle tecniche in età antica a favore delle imprese belliche, o dell’intensificazione dello sfruttamento delle risorse naturali in campo agricolo. O al modo in cui le donne, costruite come meri corpi riproduttivi, sono state private della propria libertà di autodeterminazione. Il punto è che l’orizzonte patriarcale basato sull’appropriazione da parte di alcuni soggetti della forza vitale e del lavoro di altre/i, inaugura un modo di guardare alla natura (umana e non umana) come qualcosa di «morto» (Merchant 1990) e quindi appropriabile.
Tuttavia, è con la modernità capitalista che queste tendenze si consolidano in un unico grande progetto di dominio su scala globale, sancito da forme di discorso, di sapere e di potere universalizzanti e al contempo radicali nell’operare e consolidare una scissione profonda tra umano e natura, la quale poi si articola in altre dicotomie fondanti della modernità quali quelle tra pensiero e corpo, razionalità ed emozione, uomo e donna, umano e animale, bianco e nero, ecc. Di questi dualismi, il primo termine è sempre il maggiore, quello valorizzato, il secondo minore, appropriabile, riducibile (Plumwood, 2003). Questa scissione si radica nei rapporti sociali di ri-produzione che vanno ad articolare il capitalismo per come poi si consolida. La necessità, per il capitale, di attingere a forza lavoro e risorse docili e a buon mercato per permettere e favorire l’accumulazione è stato un punto nodale della riduzione del corpo della donna a mera natura senza intelletto (e quindi senza valore) – e viceversa della femminilizzazione della natura come un che di inerte, fragile, indifeso, appropriabile e governabile (Barca, 2023; Moore, 2023).
In questo contesto emerge anche la dicotomia tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo. Il primo si muove all’interno del mercato capitalista attraverso rapporti lavorativi formali, produce merci, e quindi valore, e si pone in una relazione molto stretta con lo sviluppo delle forze produttive dentro una dinamica espansiva che sottende alla crescita infinita di capitale, alla sua accumulazione su scala globale. Questo è il lavoro reso visibile sia dall’economia politica che dalla critica all’economia politica (primo fra tutti da Marx), che lo interpretano come ciò che definisce i rapporti sociali di ri/produzione capitalisti. Si tratta di una forma di lavoro essenzialmente entropica poiché lineare (da risorse a merce a scarto) (Leonardi, 2017; Georgescu-Roegen, 2013).
Il secondo comprende tutte le attività portate avanti dalle donne e dai soggetti razzializzati per la riproduzione della forza lavoro (mangiare, vestirsi, mettere al mondo nuove persone e prendersene cura, ecc.) (si veda: Bhattacharya, 2017). Questo viene considerato come esterno al circuito del capitale e per questo svalorizzato, viene derubricato a pratica «residuale» (Lefebvre, 2014) meramente ancillare alle sfere di esistenza superiori e produttive. Oltre al lavoro riproduttivo svolto dalle donne, quello della natura non umana è anch’esso assolutamente cruciale per la riproduzione complessiva del sistema. Il contributo ecofemminista sottolinea come non si tratti di due cose differenti, ma piuttosto di un tutto in cui la vita umana è parte organica di processi oltre-che-umani circolari e iterativi fatti di dipendenze e rapporti di cura. Dal punto di vista dell’ecofemminismo critico, questo è il motivo per cui le donne sono più vicine alla “natura”. Non sarebbe una presunta essenza che le distinguerebbe dagli uomini, ma piuttosto questa quotidiana pratica di «lavoro meta-industriale» (Salleh, 2017) che le ha storicamente posizionate in uno spazio di intimità con le ecologie prossime (e distanti), così come coi corpi che vi si radicano.
Questo lavoro è assolutamente necessario e imprescindibile per la produzione, cosa che richiede di ribaltare la prospettiva rispetto alle gerarchie di valore che gli si attribuiscono (Barca, 2023). Ma la svalutazione di donna/ natura nel capitalismo è ciò che permette di appropriarsi del lavoro portato avanti dai soggetti femminilizzati e dalla natura non umana come se fosse «infinito e gratuito» (Moore, 2023). Questa capacità di appropriazione, oltre il mero sfruttamento, è centrale sia per il processo di accumulazione originaria che per il mantenimento delle dinamiche di accumulazione nel capitalismo (Picchio, 1992). I grandi studi sulla persecuzione delle streghe proprio all’avvento della modernità e in concomitanza con lo sviluppo del processo coloniale suggeriscono come l’attacco al corpo delle donne, alla sua autonomia e autodeterminazione, ai saperi che esso portava e tramandava all’interno di relazioni non riducibili alla norma eteropatriarcale, sia stato un passaggio importantissimo nello sviluppo della civiltà odierna (Federici, 2015).
Questo processo è andato di pari passo con, ed è stato permesso da, lo sviluppo della scienza moderna, la quale ha contribuito a rendere il mondo materia senza vita, parcellizzato, divisibile, quantificabile e meccanicamente morto, quindi appropriabile (Merchant 1990). Il mondo è ridotto a quantità, cosa manipolabile e misurabile attraverso dispositivi universali e astratti. Il sapere diventa allora una forza nichilista che travolge, riducendoli a quantità indifferente, natura, corpi, emozioni e singolarità. Nonostante questo modo di vedere il mondo sia il risultato estremamente localizzato e soggettivo di una posizionalità – quella dell’uomo bianco proprietario, eteronormato, razionale –, esso si pone come universale e per questo superiore a tutti gli altri, mira a ridurre il mondo a sé stesso, costituisce una linea temporale univoca della storia che misura lo «sviluppo» di ogni popolo, ogni esperienza, ogni modo di vita rispetto alla distanza da sé (Castro-Gòmez 2005). Questo è un passaggio chiave nel progetto di assoggettamento dell’intero vivente alla norma eteropatriarcale-capitalista, e si dà come dinamica alla base della crisi ecologica – poiché scienza, tecnica e capitale sono messi in grado di considerare la natura (e con essa anche la donna) come oggetto disponibile alla manipolazione, invece che soggetto definito da limiti ma soprattutto potenze.
La questione dei saperi altri, allora, è centrale. Le donne sono sempre state depositarie di saperi che avevano a che vedere con il resto della natura, il proprio corpo, l’alimentazione e la cura, che sono stati sottratti loro attraverso la violenza e la delegittimazione per essere sostituiti da saperi esperti, maschili e manipolatori, riconducibili al canone universalizzante del sapere borghese eurocentrico. Seppure nelle pratiche di gestione quotidiana della vita molte donne abbiano continuato a coltivare modi diversi di conoscere il mondo – tuttavia questi sono stati svalorizzati e ritenuti inferiori, ancillari rispetto al “vero” sapere. La rivalorizzazione, la riappropriazione e la ricostruzione di voce, spazi di espressione, competenze e conoscenze da parte delle donne diviene allora centrale in una pratica di liberazione ecofemminista non soltanto nell’ottica dell’autodeterminazione ma anche dello sforzo di ricostruire relazioni socio-ecologiche basate sull’equilibrio, la convivenza e la cooperazione (Bennholdt-Thomsen 2016).
Ripensare il materialismo
Se questa diagnosi è corretta, allora si tratta di mettere in discussione le basi pratiche e ideologiche della modernità capitalista patriarcale, per poi costruire modi di vita altri. Ci sono due passaggi fondamentali in questo senso nel campo femminista. Il primo è la critica ai dualismi gerarchici che definiscono la modernità e su cui si basano le pratiche di dominio su donna/natura. L’idea è che destrutturare questo dispositivo sia un primo necessario passo per liberare i rapporti tra i sessi, tra esseri umani e il resto della natura, ma anche tra specie, classi e “razze”. Il rifiuto del dualismo in favore di un pensiero della complessità, della relazione, di un’ontologia in cui diversi enti possano convivere non come uguali ma come pari nella differenza è centrale per la sensibilità ecofemminista.
Il secondo aspetto, che deriva necessariamente dal primo, è la necessità di ri-pensare il materialismo dentro e oltre la modernità capitalista (MacGregor, 2021). Spesso si pensa alla modernità come “materialista”, perché fortemente incentrata sulla conoscenza, la manipolazione e il controllo della materia – basti pensare alle scienze sperimentali. Tuttavia, queste forme di sapere e tecnica trattano la materia stessa come se fosse morta e senza vita, togliendole dignità ontologica. Allora, come suggerisce Bennett (2010), forse questa cultura è in fondo anti-materiale. Per l’ecofemminismo diventa importante rivalutare la materia per riconoscerne la potenza vitale e la sua capacità di inter-agire con il pensiero e la cultura umani.
In questo, gli ecofemminismi tendono a dividersi. Dal punto di vista dell’ecofemminismo spirituale, la scienza moderna ha tagliato il collegamento dell’essere umano con una spiritualità immanente, che vede l’universo come vitale e abitato da anime, spiriti, dei e dee: una sensibilità per la vitalità della materia considerata tipicamente femminile e incarnata nel corpo delle donne, le quali per proprie doti biologico-spirituali ed energetiche sarebbero maggiormente in contatto con gli aspetti incorporati, materiali. La risposta sarebbe un reincanto, una re-spiritualizzazione dell’esistenza e della natura nel suo complesso, ripristinare la potenza dell’energia femminile come principio di organizzazione delle relazioni socioecologiche.
Questa posizione è stata criticata dall’interno dell’ecofemminismo per alcuni rischi che porta con sé, come sottolinea Carolyn Merchant (1990, xxiv): … queste celebrazioni del legame tra donne e natura contengono una contraddizione intrinseca. Se le donne si identificano apertamente con la natura ed entrambe sono svalutate nella cultura occidentale moderna, questi sforzi non lavorano forse contro le prospettive di liberazione delle donne? La fusione tra donna e natura non è forse una forma di essenzialismo? Le donne non stanno forse ammettendo che, in virtù della loro biologia riproduttiva, sono di fatto più vicine alla natura rispetto agli uomini e che il loro ruolo sociale è quello di persone che si prendono cura? Queste azioni sembrano consolidare le forme di oppressione esistenti sia contro le donne che contro la natura, invece di liberare entrambe.
Questa presa di distanza rispetto all’essenzialismo non dovrebbe essere vista come un rigetto assoluto del tema della spiritualità, il cui spazio nella cultura radicale dovrebbe forse essere riconsiderato e ripensato (Degan e Castagnola 2016). Tuttavia, si tratta di non fissare una volta per tutte la donna a un’identità data.
L’ecofemminismo critico (Gaard, 2017), pur nelle sue diverse sfaccettature, è accomunato dall’intento di incarnare una prospettiva materialista, dove materialismo significa precisamente tensione verso la decostruzione di ogni universalità ed essenzialità, in favore di una concezione del mondo come radicalmente e storicamente costruito da pratiche e discorsi contingenti, sempre aperti alla trasformazione e a processi di emancipazione o liberazione basati sulla decostruzione delle norme naturalizzate. In questo, il riferimento al materialismo storico marxiano è imprescindibile, poiché si tratta di una “cassetta degli attrezzi” capace di evidenziare il modo in cui i rapporti socio-ecologici si plasmano all’interno di determinate forme di organizzazione, a cui corrispondono narrazioni e ideologie circolanti a livello sociale (Salleh, 2017).
Però l’ecofemminismo è tra le correnti all’interno dell’ampio spettro dell’ecologia politica (e dell’ecosocialismo) che per prime e più radicalmente mettono in discussione l’incapacità di Marx di includere in modo organico il lavoro riproduttivo delle donne, dei soggetti razzializzati e della natura non umana (pur avendone riconosciuto in parte l’importanza) in una teoria del valore che dia conto delle dinamiche di riproduzione complessiva del sistema. Autrici come Ariel Salleh (ibid) e Maria Mies (2001), così come Silvia Federici (2018) (pur non essendo considerata di norma all’interno di questo filone), sono partite da questa eredità per tradirla e ribaltarla. Il concetto di «materialismo incorporato» (Salleh, 2005, p. 9), ad esempio, nasce proprio dalla necessità di riportare l’ecosocialismo nella «materialità del mondo quotidiano», per portarne la politica oltre lo spazio rivendicativo della classe lavoratrice e includere nelle lotte anticapitaliste ed ecologiste il ruolo centrale del «nesso natura-donna-lavoro».
Come già detto, la donna non è allora intrinsecamente o naturalmente vicina alla natura, ma è necessario destrutturare il concetto stesso di Natura per svelarne il carattere storico. Jason Moore (2015) definisce la Natura un «progetto di classe» più che un’entità, un modo per categorizzare il mondo e costruire qualcosa di esterno rispetto alla civiltà. Questa definizione non ha a che vedere semplicemente con la dialettica padrone-proletario, ma cerca piuttosto di cogliere il modo specifico in cui le relazioni di proprietà capitaliste articolano la messa-a-valore del mondo intero. In altre parole, descrive il modo in cui il maschio bianco borghese (in quanto classe) definisce il resto del mondo come alterità, svalorizzandolo. Questa lettura si aggiunge, e non contraddice, quella ecofemminista che vede il capitalismo come lo stadio più recente della storia del patriarcato: non si tratta infatti di creare una cesura netta, ma di capire le specificità di questo modo di (ri)produzione, in cui la definizione di una Natura astratta e nettamente separata dall’uomo diventa la base per un’appropriazione senza precedenti del lavoro non umano, delle donne e dei soggetti razzializzati.
Natura è anche un concetto reificante, perché ciò che è naturale è posto al di fuori della società e del suo sviluppo e quindi – secondo questa lettura – di qualsiasi possibile processo di liberazione: è ciò che inchioda i soggetti a delle posizioni date. Un materialismo ecofemminista critico sottolinea che è nella materialità dei processi «meta-industriali» in cui sono quotidianamente coinvolte che le donne acquisiscono una coscienza del proprio essere inserite in una rete della vita fatta di interdipendenze, limite e fragilità che il contesto industriale oscura e nega poiché si compone di processi astratti, che attingono a risorse, energia e forza-lavoro estratti, trasportati, scissi dal proprio contesto originario.
Rivendicare un materialismo incorporato significa allora non solo richiamare l’attenzione sul ruolo centrale che il lavoro delle donne e della natura non umana ha nella riproduzione complessiva del sistema capitalista: si tratta anche di ricollocare l’esistenza e la sussistenza all’interno di relazioni socio-ecologiche concrete. Con Stefania Barca (2023), ripensare il mondo a partire dalle forze di riproduzione, invece che da quelle di produzione, non è semplicemente un modo per dare visibilità a soggetti spesso invisibilizzati, ma piuttosto implica un ribaltamento di prospettiva che ridefinisce le priorità dell’organizzazione sociale ed ecologica rimettendo al centro la riproduzione (Salleh, 2020).
In questo ripensamento del materialismo, il femminismo ecologico si confronta con altre correnti di pensiero (e politica) che si sono andate articolando negli ultimi decenni, primo fra tutti il post-modernismo che, per quanto un passo verso la decostruzione delle «metanarrazioni» (Lyotard, 2014) che caratterizzano la modernità capitalista e con cui si confronta l’ecofemminismo stesso, viene criticato per la sua riduzione del mondo a discorso e costruzione sociale. La necessità rispetto a questa corrente è quella di sottolineare l’importanza di dare attenzione della concretezza dei processi, soprattutto quelli di oppressione, nel momento in cui la policrisi capitalista ci pone di fronte a sfide immense a livello ecologico, sociale, economico (Salleh, 2017).
L’altro grande filone con cui l’ecofemminismo si confronta è quello dei nuovi materialismi (vedi Coole e Frost, 2010). Si tratta di una corrente composita di pensiero, ricerca e attivismo che si confronta precisamente con la svolta postmoderna per problematizzarne la cecità nei confronti della materialità, riaffermandone la centralità per ogni progetto di trasformazione sociale ma anche di comprensione scientifica e meta-scientifica. L’idea è qui quella di tornare alla materia ma senza ricadere nel positivismo, che la vedeva come qualcosa di meccanico, funzionante a seconda di leggi conoscibili e determinate, manipolabile a piacere. Il nuovo materialismo mira a destrutturare i dualismi gerarchici moderni per pensare il mondo su un unico «piano ontologico» in cui materia e linguaggio, corpo e pensiero, umano e natura si confrontano in un divenire aperto dove non esistono oggetti e soggetti chiusi in se stessi ma piuttosto il mondo si dipana in relazioni non-determinabili, dove il non umano gode di una agentività propria e non riducibile a quella umana. Questo dovrebbe risultare in rapporti maggiormente orizzontali e perciò meno caratterizzati da dinamiche di dominio nei confronti del resto della natura. Per quanto riguarda le pratiche dei movimenti, il nuovo materialismo sottolinea la centralità delle pratiche banali e incorporate della quotidianità, e non solo delle rivendicazioni simboliche, nella costruzione di mondi altri (Schlosberg 2019).
Sherilyn MacGregor (2021) ha portato tuttavia un’interessante analisi rispetto a questo dibattito, sottolineando il fatto che le preoccupazioni dei nuovi materialismi fanno parte della sensibilità ecofemminista da molto tempo, e tuttavia quest’ultima si rivela più potente nel portare avanti discorsi e alternative pratiche al capitalismo perché è capace di interrogare categorie e processi che i nuovi materialismi tendono a non essere capaci di teorizzare data la loro enfasi sulla radicale co-costruzione contingente del mondo. Ad esempio, essi non sono capaci di nominare e analizzare i rapporti sociali di ri/produzione così come sono organizzati dalle dinamiche del lavoro e del valore nel capitalismo contemporaneo, trovandosi perciò sguarniti nei confronti della critica al dominio, all’oppressione e allo sfruttamento che si articolano secondo molteplici assi quali classe, genere, razza e specie.
(continua)
Scopri di più da GognaBlog
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.