Quando mi capitò tra le mani negli anni ’70 Il più grande arrampicatore del mondo, cominciai a dubitare della concretezza delle montagne, per iniziare invece a credere maggiormente nell’espressione del gesto, dimensione reale del nostro io. Quando poi a Torino, in occasione della sua proclamazione a socio ad honorem del CAAI nell’ambito del nostro Convegno annuale, mi ritrovai accanto a lui a tavola mi sembrò di vivere in quella dimensione così eterea che Tronc Feuillu, il suo personaggio più amato, emanava. “Se potessi raggiungere la pietra senza spostare una sola goccia di rugiada, la pietra non esisterebbe più. Ed io sarei sulla sua cima“.
Ebbene, nel contributo che mi ha mandato Bernard Amy parla del cambiamento climatico facendoci immergere in un racconto, in una fiaba nella quale la realtà ci appare così tristemente vera.
Ma non basta essere consapevoli solo per pochi istanti perché alla fine del suo racconto ci ammonisce: “Dopo la lotta per raggiungere la cima, quella per la sopravvivenza umana vi aspetta sotto” (Francesco Leardi).
L’errore di Icaro
di Bernard Amy
(pubblicato su Annuario CAAI 2023-2024)
Tra tutti coloro che, come gli alpinisti, lottano contro la gravità, l’eroe mitologico Icaro è stato senza dubbio la prima vittima del riscaldamento globale.
Per comprendere meglio l’errore che ha commesso, vi racconterò prima di una bellissima escursione in alta montagna che ebbi l’opportunità di fare qualche anno fa, con un’amica, sul massiccio degli Écrins. Si trattava della classica traversata del Pelvoux, passando dal Glacier des Violettes. Conoscevo bene il percorso e avevo promesso alla mia amica una camminata senza intoppi. Invece, nulla si rivelò essere come nei miei ricordi. Il mutamento climatico aveva reso il percorso completamente diverso. Il crepaccio sopra il rifugio era difficile da attraversare, il ghiacciaio des Violettes si era notevolmente ritirato, nuovi seracchi ne minacciavano la parte inferiore. Il ghiaccio si era assottigliato, lasciando scoperte rocce moreniche friabili, difficili da risalire, per raggiungere gli alti pendii che portano all’Ailefroide. E i passaggi innevati descritti nella guida come facili da affrontare in scivolata, erano ridotti a lisci corridoi di roccia instabile, dove avevamo dovuto cercare possibili ancoraggi per la calata. Fu un’escursione molto diversa da quella che mi aspettavo, ma comunque magnifica e capace di farci sognare come solo il mondo dell’alta montagna sa fare.
Questa traversata del Pelvoux ci costrinse ad applicare una delle prime regole dell’alpinismo: saper adattare la propria conoscenza alla montagna, e non il contrario. Abbiamo dovuto ricordare che l’alpinista è colui che sa affrontare una cima o una parete in qualsiasi condizione, che si tratti di una roccia riscaldata dal sole in una bella giornata, o di un terreno trasformato dal maltempo. È anche colui che prende la montagna per quella che è nel giorno della sua escursione, sapendo che le tecniche imparate sui libri valgono quanto ciò che la montagna offre.
Da qualche anno abbiamo dovuto adattare le nostre attività invernali in quota, in particolare lo sci alpinismo. Quello che un tempo chiamavamo “sci di primavera” è praticabile solo in pieno inverno. La regolarità delle nevicate in alta quota non è più la stessa. E con i periodi caldi sempre più frequenti, abbiamo dovuto imparare a conoscere una nuova montagna invernale, in cui i pericoli conosciuti non han più lo stesso posto sul terreno e nel tempo.
Anche quando siamo andati a cercare la neve lontano dalle nostre Alpi, abbiamo trovato tracce del cambiamento climatico. Una volta, sulle alte vette dell’Atlante marocchino, abbiamo dovuto camminare per giorni su sentieri privi di neve.
È questa regola di adattamento che Icaro ha dimenticato, un Icaro troppo preso dall’ebbrezza di aver vinto la gravità e di aver potuto sperimentare, per un attimo, la libertà degli uccelli.
Ed è proprio la capacità di adattamento che permise a me e alla mia amica sul Pelvoux, nel fragile equilibrio del nostro confronto con la gravità, di non bruciarci le ali e di tornare sani e salvi a valle.
Gli alpinisti sono stati i primi testimoni degli effetti del cambiamento climatico. Ovunque sulle Alpi e sui Pirenei, i cambiamenti dei terreni sono diventati evidenti per gli scalatori abituali. Non sono tutti negativi, e la tentazione di considerare solo quelli positivi è forte, così come lo è scegliere la soluzione più facile, quella dell’adattamento.
Possiamo accontentarci di dire che, in fondo, il cambiamento climatico sta solo modificando le nostre montagne offrendoci ciò che ogni montanaro sogna di trovare: nuove cime. Sta a noi affrontarle da veri alpinisti, non solo con grande spirito di avventura, ma anche e soprattutto ricordando qual è lo spirito dell’alpinismo.
Il clima sta disegnando nuovi abiti per le nostre montagne. Ciò non toglie che una cima rimanga ciò che è: un percorso che si estende verso l’alto, un tracciato spesso mutevole, ma che ha la sua vetta. Così, la mia traversata del Pelvoux è diventata un’escursione tutta nuova. Quello che è però rimasto immutato è stata la possibilità di arrivare in cima e di vedere il mondo con gli occhi dell’alpinista, di sentire un profondo senso di potenza e di creazione interiore.
Per uscire dal labirinto costruito da suo padre Dedalo – una bella immagine del labirinto dei pensieri in parte geneticamente ereditati – Icaro non cercò l’uscita, ma immaginò di entrare nella terza dimensione, imitando un uccello.
Così come Icaro, anche gli alpinisti, per uscire dal labirinto costruito dall’infanzia e dalle relazioni parentali, hanno scelto anch’essi di scoprire la dimensione della verticalità, quella che consente loro di dare spessore alla propria esistenza. A loro basta avere delle montagne da scalare. E potrebbero pensare che ci saranno sempre vette da risalire, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Scalare o non scalare, to climb or not to climb, questa potrebbe sembrare la domanda più semplice. Purtroppo, la situazione non è così lineare, così binaria.
L’aumento delle temperature globali sta cambiando il nostro mondo. Certo, non potrà opporsi al perenne e umanissimo desiderio di elevarsi, di vincere la gravità, di sentirsi al di sopra degli uomini sia fisicamente che psicologicamente. Ma se gli alpinisti sono moderni Icaro, le condizioni del loro ingresso nel mondo della verticalità non sono più quelle incontrate dall’eroe mitologico. L’hybris di quest’ultimo gli diede la forza di avventurarsi in un mondo fino ad allora sconosciuto agli uomini. Ma il riscaldamento che non aveva previsto, e di cui è rimasto vittima, non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico di oggi. Per gli alpinisti, le circostanze odierne sono molto diverse.

Icaro non ha cambiato i raggi del sole. Gli scalatori, invece, non possono ignorare di appartenere alla specie umana e di essere quindi loro stessi in parte responsabili della crisi globale che sta modificando le loro condizioni di vita. La loro hybris li spinge ad avventurarsi nei punti più alti del pianeta. È necessario che comprendano che si tratta della medesima hybris che li ha portati a modificare le condizioni di vita sulla Terra. Da lassù si può ben vedere che l’Ecumene, la casa degli uomini e della vita, è in fiamme. Gli esseri umani stanno alterando drasticamente l’equilibrio naturale necessario per la sopravvivenza di tutte le terre abitabili che il pianeta ha concesso loro. E come spiega l’indiano Kogis Arregoces Coronado, “La natura restituisce all’uomo ciò che lui dà: violenza e distruzione”. “Se non facciamo nulla”, ci ricorda, “scompariremo”. Ci è stato donato sufficiente potere da vestire i panni dei piromani, ora sta a noi trovare il modo di ridurre gli effetti dello sconvolgimento che abbiamo causato. È tutta una questione di strategia.
Il problema è che, essendo ogni parte della casa degli uomini collegata alle altre, il fuoco si è propagato a tutte le stanze e a tutte le superfici. L’acqua dell’oceano e quella dolce, l’atmosfera, l’aria e il clima, i terreni coltivabili e i fiumi, le montagne e le zone costiere, la biosfera e la biodiversità, le aree di natura incontaminata, le risorse minerarie e l’energia disponibile, le città e le vie di comunicazione, la convivenza con i microrganismi e la salute, le regole sociali ed economiche: tutto presenta dei problemi. E chi vuole contrastare l’avanzata del fuoco si rende conto di non poter essere ovunque. Dobbiamo dividerci le battaglie. Sta a ciascuno di noi scegliere la propria, senza dimenticare di sostenere le altre!
Cosa avrebbe pensato Icaro se avesse saputo a cosa poteva portare l’hybris umana? Avrebbe sorriso tristemente vedendo gli uomini continuare a bruciarsi le ali nelle luci abbaglianti del loro potere. Dopo di lui, venne esplorato il cielo, ma non vi trovarono gli dei. La vita quotidiana degli esseri umani rimase decisamente terrena, ed ora anche drammatica.
E lasciando il fuoco in secondo piano per un istante, gli uomini continueranno a cercare luoghi in cui rivivere la nascita del mondo, la pace dell’unione con il creato e con le terre ancora quasi inesplorate, come le vette. La montagna, luogo di altezza fisica, psicologica e spirituale, merita di essere preservata come la stanza più alta del nostro oïkos, la camera da cui si scorgono molte delle bellezze del mondo, quella che può dare a ciascuno di noi il desiderio di salvare la casa dell’uomo.
E allora salite lassù! Troverete Icaro, che continua ad abitare in tutti noi.
Vi dirà che, una volta saliti, non dovrete mai dimenticare di tornare in basso, per vivere con la gente. Dopo la lotta per raggiungere la cima, quella per la sopravvivenza umana vi aspetta sotto.
Scopri di più da GognaBlog
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
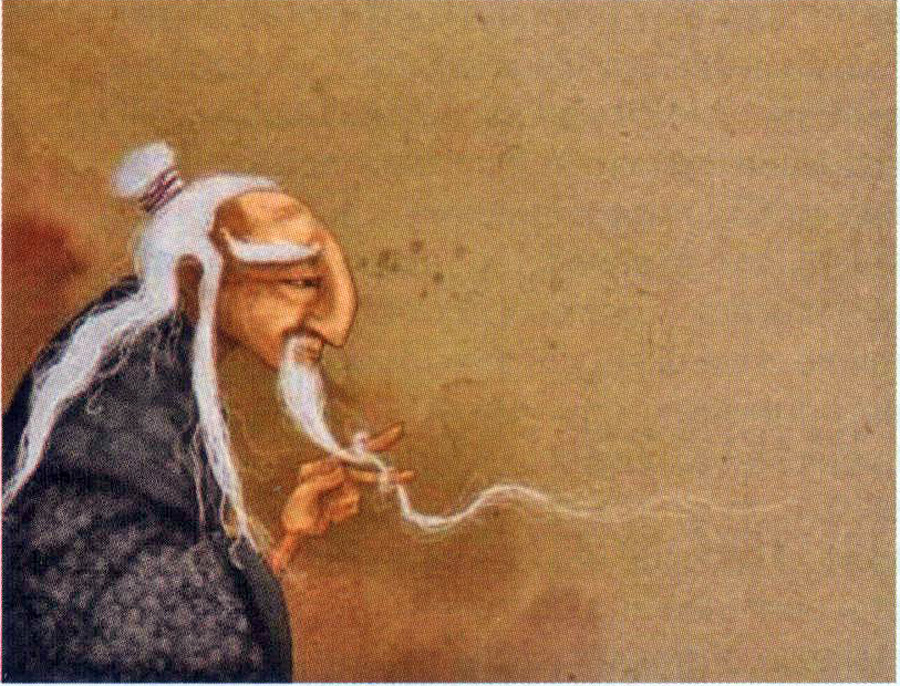
Veramente io ho scritto che ogni buon alpinista, come anche Icaro, si spinge oltre i limiti della tecnologia
No non contraddice nulla. Mettere una sosta resinata non è così semplice come sembra a prima vista. Ci sono delle regole tecniche da rispettare. Se non ne tieni conto e resini male , i golfari dopo un pò si muovono e quindi un sosta fatta nella convizione che regga una nave, in realtà è insicura e pericolosa. Molto pericolosa perchè le persone danno per scontato che sia sicura. Ma non è un limite tecnilogico è un limite o ignoranza umana. Anche perchè un chiodo a fessura per metterlo ci vuole una fessura, un resinato basta avere il trapano e lo metti praticamente dove vuoi. Certo non nella roccia friabile o nei pressi di una fessura.
@Expo il mio è un concetto diverso.
Qualcuno ha scritto che la morte di ogni buon alpinista è causata dai limiti tecnologici.
Secondo me non è così perchè in alpinismo il fattore umano è ancora (per fortuna) assai determinante, perchè oggi nessuno si lega più in vita e con una corda di canapa.
Se poi vogliamo rifare il solito confronto cosa è meglio tra spit si o spit no. Lasciamo perde.
Che contraddice ciò che hai detto al 10
E’ quello che ti ho scritto al punto 3.
@ Alberto
.
.
Voi avrete pure piu’ esperienza , se io vado sul mio limite preferisco avere un resinato che un cordino marcio da verificare / rimpiazzare.
.
.
Un conto e’ parlarne qui , davanti a un caffe’ , un conto e’ arrivare davanti a un ancoraggio inaffidabile e metterci mano mentre sei ghisato e ti tieni.
.
.
Io ricordo alpinisti molto migliori di me , che sono venuti giu’ insieme alla sosta da cui si stavano calando , quindi nella situazione in cui rinforzarla era banale.
Se resinata male è colpa del muratore…..non della tecnologia.
Ovvio che Giove ride del sempre e del mai degli uomini.
In fondo, Icaro, proprio per la sua caduta ha quasi raggiunto l’immortalità…meglio di molti poveri alpinisti
NON E’ VERO!!
Dipende se è resinata bene o male.
E comunque di eterno ci sono solo io!!
“Una sosta resinata non cede
Un cordino in poliammide non invecchia”
Sicuro, sicuro?
-Definire un “incidente” un fatto è uno dei modi migliori per sottrarsi al fastidioso compito di indagare la causa del fatto stesso: cosi, quando qualcuno mi viene a dire che la storia è un susseguirsi di eventi accidentali, sono incline ad attribuirgli una certa pigrizia o scarsa energia intellettuale.-
Da:
“Sei lezioni sulla storia” , di Edward Carr, 1961
Icaro è morto perchè:
– non aveva preso il brevetto di volo con ali di cera.
– abbattuto da un drone perchè entrato nello spazio aereo nemico.
– abbattuto da 2 F35 intercettori perchè era stato perso il contatto con torri di controllo.
– non si saprà mai, come per Ustica!
Possono essere tante le cause della sua caduta.
Una sosta resinata non cede
Un cordino in poliammide non invecchia
Il chiodo si stacca perchè è messo male oppure è marcio.
Il cordino si spezza perchè è marcioo lesionato.
Non è un problema tecnologico, è di valutazione.
Se icaro avesse avuto ali di resina starebbe ancora volando.
Come molti cui si è staccato un chiodo o rotto un cordino
Non è la tecnologia che fa morire o vivere un alpinista.
Icaro è morto perché ha superato i limiti della tecnologia che aveva a disposizione
……come ogni buon alpinista
Preferisco immaginare che Icaro sia stato vittima della sua arroganza (hýbris) e non del riscaldamento globale, altrimenti dovrei pensare che il clima non sia cambiato. Come invece suggerisce la scienza contemporanea.