È un fenomeno sempre più rilevante: pezzi interi della «generazione perduta» cercano rifugio e possibilità in montagna. Costretti da una crisi e da una precarietà infinite, uomini e donne si spostano fuori dalla città, in un complesso movimento migratorio «al contrario», tutto da scoprire e interpretare. Nascono così progetti di vita innovativi, basati su modelli alternativi di sviluppo, sulla green economy e sulla soft economy. Nascono nuove storie e nuove creatività. Vecchi borghi vengono ripopolati. Antiche strade vengono risvegliate. Via dalla città, di Maurizio Dematteis, è un libro di paesaggi, di ritratti e di racconti. Un libro di montagna, e di inchiesta.
Ne presentiamo il capitolo “Un mondo che bussa”.
C’è un mondo che bussa
di Maurizio Dematteis
(da Via dalla città, di Maurizio Dematteis, Derive Approdi, gennaio 2017)
Enrica sembra aver sempre vissuto a Ostana. È una donna tranquilla, di media statura, mezza età, curiosa e discreta, curata nel fisico e nel vestiario, una montanara per scelta.
L’ho conosciuta un giorno proprio al rifugio Galaberna di Ostana, era ancora una villeggiante saltuaria che da Milano veniva spesso, tutte le volte che aveva qualche giorno di vacanza, in Valle Po a riposarsi e a fare il pieno di «ambiente» e socialità. Ha cominciato con un campo di lavoro di Legambiente ed è rimasta subito colpita dalla realtà del piccolo comune cuneese: dopo una decina di giorni passati a pulire i sentieri nei dintorni delle borgate si è accorta di avere trovato una realtà particolare. «Diversa», come dice lei. Una comunità in cui «si respira un’aria particolare», dove residenti e villeggianti concorrono insieme alla «rinascita» di un comune alpino. Dopo la prima esperienza di volontariato Enrica è tornata molte volte a passare periodi di vacanza a Ostana fino alla decisione che l’ha portata a legarsi definitivamente al piccolo comune alpino: ha acquistato una casa da ristrutturare nella piccola borgata di Sant’Antonio, Miribrart in lingua occitana, frazione interessata dal Progetto borgate della Regione Piemonte, dal quale Ostana ha ottenuto due milioni di euro di finanziamento per il recupero delle vecchie case in pietra.
«La borgata diventerà un esempio per quanto riguarda» il reinsediamento alpino in Italia – mi raccontava Enrica qualche anno fa mentre era già stata coinvolta nel contesto – Un centro polivalente realizzato dal comune per iniziative culturali, una serie di professionisti (informatici, allevatori, caseificatori, consulenti aziendali) che porteranno la loro attività nella borgata grazie al collegamento a Internet». Ricordo di aver pensato: «Auguri! Tra un paio d’anni lei sarà ritornata a Milano e del progetto chissà cosa ne sarà…».
Oggi tomo a Ostana, in Valle Po, a trovare Enrica a cinque anni di distanza, e scopro con stupore che nel frattempo non solo non ha rinunciato a seguire il suo progetto, ma ha definitivamente abbandonato Milano! Ha preso la residenza in questo piccolo comune montano con grande entusiasmo e il suo impegno nella comunità locale aumenta di anno in anno. Arrivare a Ostana con i mezzi pubblici è stata una vera impresa: nessun problema fino a Paesana, con circa due ore di viaggio per coprire i 70 chilometri che la separano da Torino. Parto alle 9, cambio a Saluzzo, e in poco più di mezzora arrivo in bassa valle; a Paesana alle 11. Poi il nulla, a meno di non prendere l’autolinea scolastica che risale la Valle Po fino a Crissolo, che però, leggo dal sito sul mio smartphone, con l’orario invernale, quello del periodo scolastico, sale solo due volte al giorno, e mi par di capire che si può essere presi a bordo solo su richiesta telefonica da realizzarsi almeno due ore prima. Accidenti.
Dalla fermata mi incammino lungo la Strada provinciale 26 che risale la valle con l’idea di fare il buon vecchio autostop. Di giorno infrasettimanale però non è che passino molte automobili dirette verso l’alta valle, così solo dopo una mezz’oretta di cammino passa la prima auto: niente meno che quella di Giacomo, il sindaco di Ostana. Giacomo è un amico, un omone alto e arruffato che ha speso la vita per il suo comune di nascita, Ostana, e da quando è in pensione ha aumentato il suo impegno portandolo a tempo pieno, compresi sabato e domenica. Capita di vederlo la sera pulire i canali di scolo dell’acqua intorno al paese e il mattino dopo SU un palco di un convegno internazionale a parlare di sviluppo montano. Giacomo è un amministratore capace di tenere i legami con tutti, dai residenti del piccolo comune, che lo conoscono e si fidano di lui, ai ministeri nazionali, che pendono dalle sue labbra quando lo sentono parlare di sviluppo locale e recupero della socialità in montagna, cose che spesso a differenza sua loro non conoscono e nemmeno riescono a immaginare.
Ebbene, il grande sindaco del piccolo paese insieme a un pugno di uomini capaci è riuscito ad attuare un vero e proprio «miracolo», trasformando un minuscolo e sperduto borgo montano a 1300 metri di altitudine sulle Alpi Cozie da luogo di fuga a porto sicuro.
Mi prende a bordo e comincia a raccontarmi la storia di Qstana: «Tutto è nato nel 1985, quando abbiamo fatto una lista civica forte e abbiamo vinto le elezioni comunali. La domanda che ci siamo posti è stata “quale futuro per un paese ormai ridotto a ospitare cinque persone anziane residenti?”».
Mentre risaliamo la valle a velocità sostenuta, e scruto preoccupato l’acqua che scende nell’orrido del fiume Po all’ombra delle pareti scoscese della valle, Giacomo non nasconde una certa soddisfazione per i risultati ottenuti, e mi racconta del lento lavoro messo in campo per invertire la tendenza dello spopolamento nel suo comune: a fine Ottocento Qstana contava oltre 1.400 abitanti, tra agricoltori, allevatori e artigiani, che nel 1985 si erano ridotti ai cinque superstiti e anziani. Ma nel 2011, grazie al trentennale lavoro della sua amministrazione comunale «illuminata», i residenti sfondano quota 90, di cui sei bambini. Un messaggio di speranza per il futuro. «Partivamo da un patrimonio importante: l’integrità del comune dal punto di vista ambientale e architettonica. E abbiamo deciso di lavorare su quello. È stato un lavoro lungo, ma oggi la gente ci crede. Prima si portavano gli avanzi architettonici dalla città: vecchie finestre recuperate, porte in formica, mobili in disuso, campionari di piastrelle. Perché quello che non serviva più giù poteva essere utilizzato qui. Ora se qualcuno non rispetta le indicazioni urbanistiche, se non si rispettano gli equilibri architettonici e ambientali, la gente viene a lamentarsi direttamente in comune».
Grazie a un sapiente mix di competenze messe a disposizione da tecnici preparati, di studi realizzati dal Politecnico di Torino e all’apporto di indicazioni da parte di residenti e profondi conoscitori della realtà alpina e locale, Ostana ha cambiato faccia: oggi ha un ingresso al paese ridisegnato con materiali a basso impatto architettonico, un rifugio albergo gestito da due «nuove» famiglie, una porta di valle che promuove prodotti e territorio, una palestra di arrampicata, un centro benessere autosufficiente dal punto di vista energetico, illuminazione stradale con pannelli fotovoltaici, due centraline idroelettriche sulle captazioni dell’acquedotto, addirittura una rinomata «scuola di cinema» gestita da Fredo Valla e da Giorgio Diritti, artefici del famoso film Il vento fa il suo giro (1), successo del 2007 che ha tenuto le sale cinematografìche per mesi in molte città d’Italia.
E poi un’intera borgata recuperata, quella in alto, Miribrart, che da abbandonata con i tetti e muri cadenti oggi è irriconoscibile: edifici ristrutturati, strade lastricate e un centro pubblico denominato «Lou pourtoun», un trionfo di legno, pietra e vetrate che uniscono quattro strutture con una corte centrale da utilizzare per incontri, mostre ed eventi, un recupero innovativo e funzionale su cui hanno messo gli occhi istituti universitari e società per poter offrire corsi di formazione su temi riguardanti la montagna, con vista Monviso.
Una trasformazione che ha coinvolto tutti i livelli gestionali, partendo dall’amministrazione comunale, che poco alla volta è riuscita a ottenere un certo riconoscimento e sostegno sempre più in alto, dalla Regione ai ministeri fino all’Unione europea. Un circolo virtuoso di politiche multilivello partito dal basso che ha richiamato persone disposte a spendersi all’interno della comunità, proprio come Enrica, che arrivata attratta dalle bellezze naturali, ha scoperto un inaspettato mondo sociale, culturale e politico che l’ha letteralmente rapita.
Mi accoglie sulla porta della sua casa in pietra completamente ristrutturata, all’interno di una borgata che rispetto a una decina di anni fa sembra irriconoscibile.
Nel frattempo sono passate di qui le migliori menti dell’architettura alpina contemporanea, le più stravaganti e innovative idee sul recupero e utilizzo degli spazi e una serie di folli pionieri disposti a mettere in pratica le tante idee teorizzate. «C’è un mondo che non può più esistere e un altro che sta bussando – rompe il ghiaccio Enrica – Il primo è l’eredità del «mondo dei vinti», fatta di abbandono, avanzata dei boschi, piccole proprietà di terreni e immobili ormai abbandonati che negli ultimi trent’anni hanno accompagnato a un lento e inesorabile declino i territori alpini italiani.
Dall’altra parte il nuovo che cerca di avanzare. Quello che l’amico Aldo Bonomi, con la sua proverbiale capacità di sintesi, descrive così: «Un puzzle di contesti locali sospesi tra il non più e il non ancora, tra “mondo dei vinti” e avanguardie agenti, tra smart city e smart land, un mondo che viene avanti, piuttosto che uno che va declinando, come vorrebbe l’immaginario alpino prevalente».
Secondo Aldo questo ritorno alla montagna non è necessariamente legato alla nostalgia, «all’adagio pavesiano del “resta sempre lassù il paese”, ma può essere dettato da motivazioni che attengono alla voglia di mangiare futuro». E la montagna «non è più periferia o margine, ma centro», dove i nuovi montanari sono «un segno di speranza di un possibile non ancora che verrà». In realtà, dice Enrica, a Ostana il «non ancora» è già realtà. «E per fortuna non si tratta più di grattacieli o speculazioni ma di sviluppo sostenibile. Per questo sono venuta ad abitare qui».
Nata a San Remo, in riva al mare, Enrica si è trasferita a studiare a Milano, dove ha preso la residenza ed è rimasta poi a vivere per oltre dodici anni. «Ho studiato alla Statale e mi sono laureata in scienze e tecniche alimentari, poi un anno di ricerca in Inghilterra e il dottorato in chimica alimentare in Portogallo, sempre con l’idea di tornare a casa, a Milano». Finito il periodo formativo qualche anno di ricerca da «precaria» al Cnr e poi, finalmente, il tanto agognato «posto fisso», presso l’Università di Como come tecnico di laboratorio. «Ero felice a Milano, pendolavo su Como in circa un’ora con il treno e facevo il lavoro per cui avevo studiato e mi ero dottorata». Enrica ha addirittura comprato casa in città, nel grande quartiere della Bovisa. «Pensavo che la mia vita sarebbe stata lì, tra passeggiate al Parco Lambro, gli amici e il lavoro».
Poi, inaspettato, si fa largo pian piano il «richiamo della montagna». Comincia ad andarci nei weekend, da Milano, accompagnando i ragazzi dell’associazione Panda trek, e si risvegliano in lei i ricordi di quando, da ragazzina, andava in montagna con il CAI ligure.
«Avendo ricominciato a frequentare la montagna, quando tornavo in città “quella cosa lì” mi mancava, e poi in quel periodo, da cittadina ho fatto molti pensieri sul sul consumo critico, sulla decrescita, sulla ricerca di stili di vita diversi, mi ero avvicinata ai gruppi di acquisto sostenibile e frequentavo un giro di persone con cui ragionavamo su come sperimentare una vita diversa, con meno sovrastrutture, per andare verso l’essenziale.
E questo pensiero, tutto questo processo, per me era possibile in montagna. Dove si possono togliere le cose superflue e capire quali sono quelle che servono veramente. Un percorso più facile da percorrere in montagna, perché in città hai tante interferenze che lo rendono più difficile».
Enrica ha amato molto Milano, tutte le volte che ci tornava era contenta, ma alla fine il «richiamo della montagna» è stato più forte: «pian piano stavo maturando inconsciamente la volontà di stare. Son tornata tante volte a Ostana dopo quel primo campo di volontariato con Legambiente e ho aderito in modo istintivo al progetto di recupero della borgata acquistando una casa da ristrutturare».
Ma prendere la residenza e staccarsi da Milano era ancora una fantasia. «La concretizzazione del sogno è arrivata quando mi hanno chiesto di mandare il curriculum all’Achillea di Paesana, dove cercavano un responsabile della qualità». All’inizio Enrica è disorientata, in fondo non è quello il suo lavoro, quello per cui ha studiato. E poi ha il posto fisso, in città. Ma ripensa al percorso di avvicinamento alla montagna fatto fino a quel momento, e realizza che se non si mette in gioco non arriverà mai l’opportunità.
«L’ho fatto un po’ per scherzo e quando mi hanno comunicato che mi avrebbero assunto mi è venuta una fifa blu! C’ho messo una settimana a decidere: poi mi son detta, ma scusa, ho trovato lavoro, la ristrutturazione della casa sta per finire e se non lo faccio adesso non lo farò mai più. In fondo treni così non è che ne passino molti nel corso della vita».
È fatta, Enrica prende un anno di aspettativa e si trasferisce ad Ostana. «Ricordo ancora che quando ho chiuso casa a Milano mi sono messa a piangere, e pensavo che in fondo si piange anche quando si va verso prospettive più belle, e che alla fine nella mia vita ho sempre avuto fortuna, e che in definitiva ero proprio contenta».
Finito l’anno di aspettativa Enrica si licenzia dall’Università di Como, ormai la scelta è definitiva. Nei mesi precedenti gli amici con cui si è confidata prima della «grande scelta» si dividevano tra gli entusiasti, quelli che erano sicuri fosse la scelta giusta e che lo avrebbero sicuramente fatto anche loro se solo… e gli altri che erano altrettanto sicuri fosse un azzardo. Ma ormai alea iacta est e quando uno si convince finisce per ascoltare solo gli amici che gli danno ragione.
«Da quando mi sono trasferita mi vengono a trovare spesso. Una mia cara amica un giorno mi ha detto che sono un faro perché ho fatto “la scelta”; un altro che è da una vita che ci pensa, e che grazie al mio esempio forse finalmente farà anche lui la mia stessa scelta, anche se sono sicura che anche questa volta non ci riuscirà, perché come tanti non è ancora convinto di lasciare le supposte sicurezze della città».
E poi c’è la famiglia, il papà, mancato recentemente, e la mamma, che non l’hanno presa benissimo. Sono originari dall’entroterra ligure di Genova, Conio, frazione del comune di Borgomaro, e una realtà come Ostana alla loro generazione ricorda ancora la fame e la guerra, qualcosa da cui scappare. Il papà di Enrica aveva quattro sorelle, tutte andate a vivere via, verso un mondo di pianura «più facile». E vedere la figlia che lascia la città per la montagna è come assistere a un ritorno indietro.
«Mia mamma, anche lei, non l’ha vissuta bene, l’ha vista come una grande pazzia. Adesso comincia a conoscere l’ambiente di Ostana e soprattutto vede che sto bene. Ma per lei rimane una cosa fuori dal comune, perché la scelta di lasciare la montagna è stata quella che ha garantito un certo benessere alla nostra famiglia: mio papà faceva il ferroviere, mia mamma le pulizie e io ho potuto studiare a Milano. Il loro riscatto è stato quello e faticano a comprendere che il mio possa essere questo. È proprio un mondo diverso».
Oggi Enrica vive in borgata Miribrart da sola. Ma ci tiene a sottolineare che non è «venuta qui per fare l’eremita». Anzi, quando d’estate la borgata si anima lei e felice, e patisce anche un po’ il lungo inverno, sola con la neve. Appena riesce esce e va in cerca di persone interessanti. «Oggi ad esempio era una splendida giornata autunnale e tornata dal lavoro sono andata a fare una bella passeggiata. Non è la stessa cosa che andare a Parco Lambro, perché qui ti assapori le stagioni, è un’altra vita, non c’è niente da fare».
E passeggiando per le strade della borgata capita ad esempio di incontrare un gruppo ragazzi tedeschi, che insieme al professore universitario e imprenditre tedesco Tobias Luthe (2) hanno comprato una piccola borgata sette od otto case, per farne la sede di una scuola sperimentale di sostenibilità.
Capita di assistere all’inaugurazione del centro polifunzionale “Lou pourtoun”, a poche centinaia di metri dalla casa di Enrica, con un centinaio di persone salite a vedere la mostra «Poesia del vero. Il paesaggio montano dall’800 al contemporaneo» curata da Cinzia Tesio con esposte, a Ostana, opere di Lorenzo Delleani, Carlo Carrà, Mario Sironi, Filippo De Pisis, Giulio Boetto, Andrea Tavernier, Cesare Maggi, Leonardo Roda, Matteo Olivero, Italo Mus, fino allo scultore contemporaneo di Paesana Michelangelo Tallone. E ogni settimana se ne studiano una, quelli di Ostana, per rivitalizzare i borghi.
Chiedo a Enrica se non si è pentita della scelta fatta, così, secco, senza tanti giri di parole. E se non ha mai avuto dei momenti di difficoltà. La risposta è altrettanto secca: no. Non si è pentita, assolutamente. Lo rifarebbe sicuramente, e anche se i momenti difficili non sono mancati, sono quelli belli a prevalere, nettamente. E non rimpiange la vita di prima. «Qui c’è una direzione chiara, è una comunità che sa dove vuole andare, esiste un disegno condiviso. Senza deleghe». Ed Enrica, che non è una persona che si tiri indietro, quando ci sono state le ultime elezioni nel 2014 è addirittura entrata nell’amministrazione comunale. «L’ho fatto volentieri, ci sono delle cose da fare e le faremo nei prossimi cinque anni. Piccole azioni, ma che possono avere un grosso impatto sul futuro del nostro piccolo comune. Ad esempio l’associazione fondiaria, creata per cercare di accorpare terreni privati abbandonati o incolti e poterli dare in gestione ad aziende agricole interessate». Come quella di Serena, 23 anni, neo laureata in scienze erboristiche che ha deciso di venire a vivere a Ostana per coltivare cavoli, finocchi e altre verdure. Il Comune le ha già affidato un appezzamento di terreno e appena riuscirà ad «accorparne» un altro lei potrà allargare la sua azienda agricola, in modo che torni in valle l’agricoltura di montagna.
Enrica con i colleghi dell’amministrazione ha fatto un importante lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari dei terreni. E anche se rimane ancora qualcuno restio ad affidare le sue terre abbandonate, come si dice a Ostana: «l’ottimismo prima o poi trionferà».
«Quando ci penso mi viene in mente che alla fine non è una cosa poi così eccezionale quello che ho fatto. E a volte mi viene da ridere, perché io nel corso della mia vita ho girato il mondo, ho fatto tante cose, ma mai nessuno si era interessato a me. Dovevo proprio venire a vivere a Ostana perché qualcuno venisse a intervistarmi!».
Note
(1) Il vento fa Usuo giro, Aranciafilm Imago Orbis Audiovisivi, 2005. Giorgio Diritti ne firma la regia.
(2) Vedi www.tobiasluthe.de.
Scopri di più da GognaBlog
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

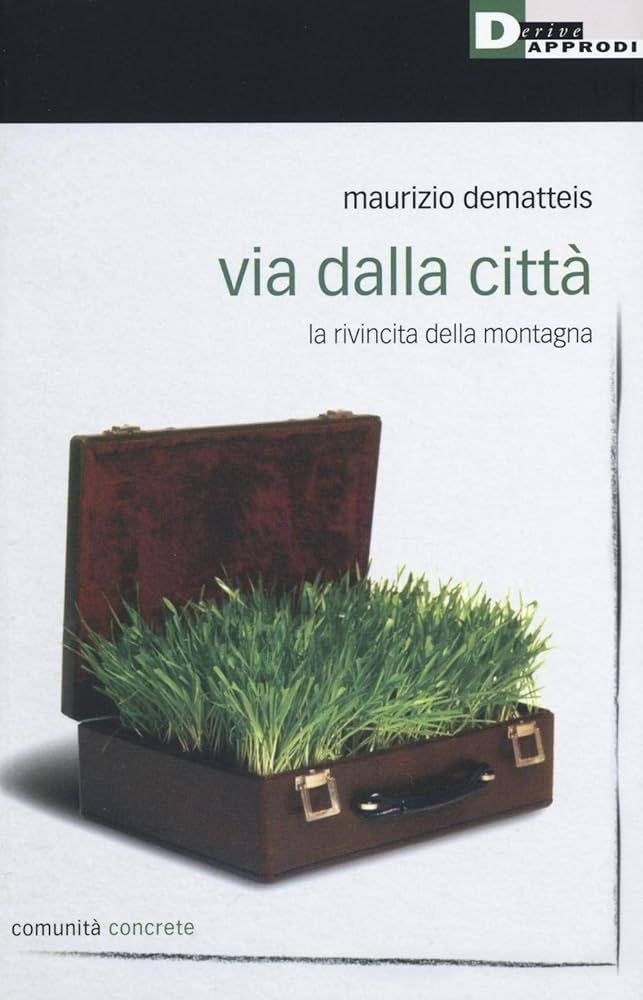


Saluti.
Ho girato p.c. l’articolo ad un paio di sindaci di piccoli comuni di montagna.
Saluti.
Massimo Silvestri