Parlando di “confine” è facile trovarsi in compagnia del concetto di “limite”. In effetti le due parole hanno acquisito significati che qualche volta si confondono, quando addirittura non coincidono. Non per nulla “confine” deriva da Cum = “con”, “assieme a” e Finis = “limite”, “termine”, “fine”.
Confine e limite
Il confine
Nell’accezione comune “confine” è prima di tutto una convenzione, frutto evidentemente di un accordo che, riconosciuto e firmato da almeno due parti, è da queste rispettato per una convivenza pacifica.
Io riconosco a te, che abiti o che possiedi ciò che è oltre a questa linea, il pieno diritto di viverci o di esserne proprietario; allo stesso modo tu riconosci gli stessi diritti a me che possiedo l’al di qua di questa linea o ci abito.

Seguendo determinate procedure, più o meno rigide e complesse, le due parti possono valicare la linea di confine ed essere quindi “ospiti” in territorio altrui. La durata di questi soggiorni può essere assai varia, qualche volta la permanenza può essere definitiva. Gli scopi di questi “sconfinamenti” sono anch’essi vari, anche se grosso modo possiamo distinguere tra quelli turistici, quelli commerciali e quelli derivanti da una fuga, sia questa dettata da motivi politici che da ragioni umanitarie o calamità naturali.
Sostanzialmente il confine regola i rapporti tra i corpi fisici, precisando quanto è lecito che l’ospite possa fare e quanto no, mentre in genere nulla può contro la diffusione delle idee e degli esempi di civiltà.
Quando il confine non è rispettato si possono creare situazioni di tensione, di reciproche contestazioni, fino ad arrivare al caso estremo della guerra.
La costruzione dei muri sottolinea la dimensione di minacce di aggressione (la Muraglia Cinese) oppure l’estrema difesa di un regime che insiste nel privare della libertà i propri cittadini (il Muro di Berlino) oppure ancora la protezione da immigrazioni che potrebbero scardinare equilibri di ordine economico (il muro voluto da Trump tra USA e Messico).
In questo genere di situazioni chi la fa da regina è la paura, qualche volta giustificata ma più spesso irrazionale, quando non pilotata da una minoranza al potere.
Ci si aggrappa al confine (e lo si difende inflazionandone il concetto) quando ogni forma di dialogo è sospesa, quando l’ascolto reciproco sembra diventare un’ipotesi estranea alla realtà.
Il confine in se stesso non è né buono né cattivo, è solo uno strumento che come tanti altri strumenti può essere usato nelle più diverse funzioni. Non è che lo strumento coltello sia cattivo se qualcuno ogni tanto lo usa per uccidere o ferire.
In una situazione pacifica il confine impaurisce solo chi già a monte ha motivo di avere paura. Altrimenti non è altro che uno strumento che regola la nostra conoscenza degli altri e del loro territorio. In una situazione pacifica il confine sottolinea sì delle differenze (lingue, costumi, culture, a volte religioni): ma queste è bene siano vissute come occasioni di arricchimento e non di minaccia. La piena accettazione e il riconoscimento integrale delle differenze è l’unica grande occasione che abbiamo per crescere come individui e come collettività.
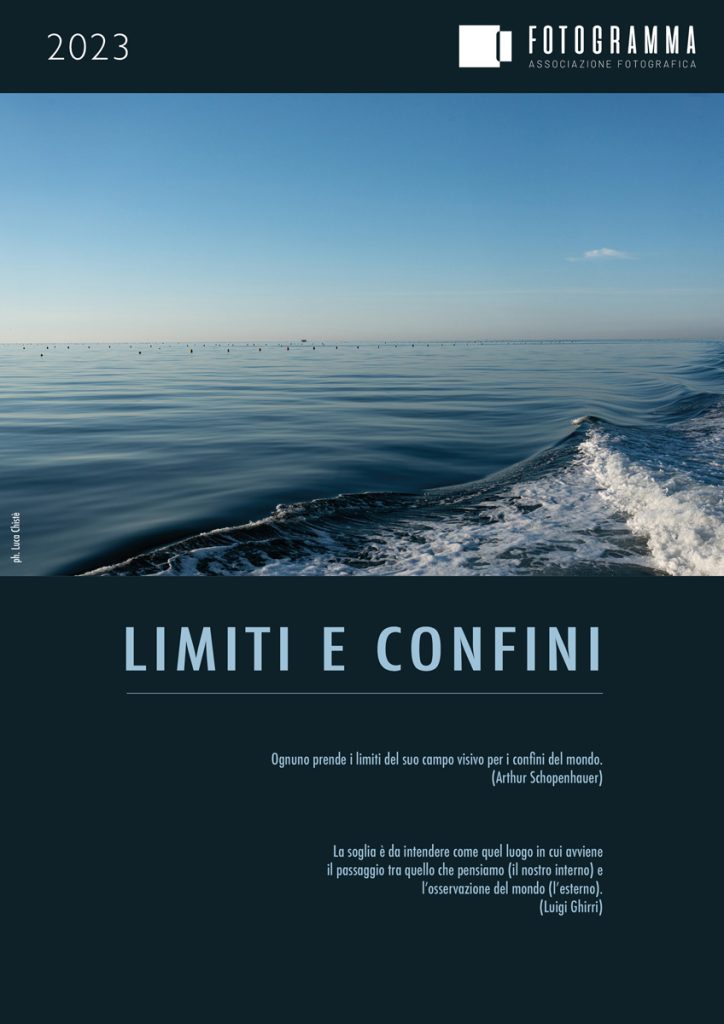
Abbiamo parlato finora di confini territoriali, ma in tutta evidenza il discorso si può allargare in questa chiave anche ai confini culturali o etnici. Con la paura si erigono muri, con l’amore i confini sono linee da interrogare, attraversare, relativizzare. Proprio perché “amore” è la cura dell’altro da sé.
La storia dovrebbe farci riflettere sulla natura dei confini culturali, etnici, linguistici che vengono presentati come “di qua/di là”: non riflettono la vera natura dei popoli. Sono costruzioni politiche, artificiose, culturali, il più delle volte arbitrarie.
Le tensioni etniche e culturali spesso derivano da leggi, strutture, politiche che enfatizzano artificiosamente la separazione etnica o che cercano di risolvere problemi con forzature territoriali (annessioni, modifiche di confine) piuttosto che con rispettosa convivenza.
Se di ciò facciamo certezza, diventa facile (come facile per esempio è per la nuova generazione dei giovani europei) saltare muri, attraversare confini, promuovere figure e progetti che siano ponti e mediatori tra comunità. Non per eliminare le differenze, ma per farle dialogare. Alex Langer parlava esplicitamente di “mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera”.
Ciò appare ancora più evidente se per un momento abbandoniamo il nostro sempre latente isolazionismo, il protezionismo delle proprie piccole realtà e consideriamo che la nostra identità non sia mai qualcosa di autosufficiente, ma si formi e si costituisca anche nel rapporto con l’altro da sé (nell’accezione che gli antichi davano alla parola “sacro”). Il confine è il punto in cui “tocco” l’altro, dove mi confronto, dove posso cambiare pur restando me stesso.
Riconoscendo dunque al confine l’essenziale “bontà” e utilità di base, non si tratta di abolire ogni confine, ma di renderli meno rigidi, meno “spinati” (nel senso di ostili), più permeabili, che possano essere attraversati, discussi, contestati: una specie di contrabbando delle culture.
Insomma, un confine inteso non solo come divisione ma come luogo di incontro, opportunità, trasformazione: in definitiva, di apertura.

Il limite
La parola limite si presta a diverse interpretazioni, occorre essere dotati di un minimo di agilità di pensiero per poterla usare con rispetto e non a sproposito.
“Limite” può essere una costrizione negativa, qualcosa che frena; ma il suo significato va ben oltre quando si riconosce che è tramite il limite che ci può essere ricchezza interiore, responsabilità, misura, in definitiva vera “libertà”: è la pietra angolare di un’etica, di uno stile di vita, di una politica responsabile. Non può esserci crescita, convivenza o sostenibilità senza riconoscimento del limite. Non ci può essere libertà senza il limite.
Nella nostra epoca storica, contrariamente a quanto avvenuto nell’Ottocento e nel Novecento, comincia a farsi strada l’idea che non si possa sempre “fare di più, produrre di più, consumare di più, dominare sempre di più, controllare di più”.
Oggi infatti si parla di limite anche in relazione al pianeta: limiti all’uso delle risorse, limiti all’inquinamento, limiti alla pressione che l’umanità esercita sugli ecosistemi. Accettare limiti significa evitare danni irreversibili, proteggere la biodiversità, evitare che il presente comprometta il futuro.
Quindi sobrietà di consumo, rallentamento dei ritmi (di vita, di produzione), minor impatto della tecnologia: non come regressione ma come consapevolezza, come trasformazione culturale.

Appare sempre più evidente che lo sviluppo non può essere quantitativo e “illimitato” se continua il disprezzo delle risorse, delle conseguenze, dell’impatto sull’ambiente e dell’ecosistema.
Sempre più si parla (anche se spesso non si agisce in quel senso) di “consapevolezza del limite” come di una virtù, nel contesto di una “civiltà green”, che impone rinunce, autolimitazione, soprattutto modestia.
Alex Langer ha insistito sulla doverosità di un dialogo critico con la cultura dominante del progresso illimitato, della crescita a tutti i costi, della modernità accelerata. Un esempio per tutti la sua contrapposizione al motto olimpico citius, altius, fortius (“più veloce, più alto, più forte”) con una sua variante: lentius, profundius, suavius (“più lentamente, più profondamente, più dolcemente/soavemente”) come espressione del limite, della misura, della riflessione.
Purtroppo la nostra civiltà estrattivista non solo ci impedisce di non accettare i limiti imposti dalle circostanze, ma vorrebbe imporci di non pensare neppure all’opzione anticipata di non oltrepassarli per non provocare danni irreversibili.
Il momento del contatto
Come individui abbiamo i nostri limiti (corporei, psicologici, relazionali). Poi ci sono i confini tra noi e gli altri, tra il conoscere e il non conoscere, tra ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo.
Dunque limite e confine non sono solo barriere: dove c’è limite io posso incontrare l’altro, posso essere “toccato” emozionalmente e toccare, posso rischiare di essere ferito ma anche di costruire una relazione.
Con gli strumenti del confine e del limite si tratta, in definitiva, di aprire al futuro.
Scopri di più da GognaBlog
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
Come si dice spesso, meglio costruire ponti che alzare muri. Però non tutti hanno la stessa intenzione. È un fatto per esempio che è stato il papa cattolico ad invitare a Roma un re scismatico e offrire una riconciliazione, e non viceversa. Per evitare lo scontro la civiltà ha bisogno di qualcuno che faccia il primo passo, sia pure modesto.