Il grande momento dell’alpinismo francese
di Gian Piero Motti
(pubblicato in Storia dell’Alpinismo) (GPM-SdA-33)
Abbiamo visto precedentemente come la salita compiuta da Bonatti sulla parete est del Grand Capucin avesse aperto la strada a molte altre realizzazioni future, rese teoricamente possibili dalla certezza di riuscire a passare su delle strutture granitiche analoghe a quella del Capucin. Abbiamo anche visto che i primi esponenti di valore dell’alpinismo francese del dopoguerra furono soprattutto dei ripetitori coraggiosi delle vie aperte prima del conflitto dai capiscuola dell’alpinismo italiano e tedesco. A seguito di questo primo gruppo, vediamo giungere alla ribalta delle Alpi Occidentali un nucleo di arrampicatori parigini della scuola di Fontainebleau, quindi abilissimi nella scalata su roccia pura. Nel gruppo primeggiano soprattutto Lucien Bérardini, Robert Paragot, Luciano Magnone. Molte cose nell’alpinismo francese sono assai mutate dopo la guerra: ormai anche in Francia l’alpinismo è dominio delle classi sociali meno agiate e siamo dunque lontani dai tempi dei Lépiney e del GHM che raccoglieva un mondo piuttosto aristocratico. Questi ragazzi non hanno certo vita facile ed è gente che per vivere si arrangia un po’ come può, dati anche i tempi duri. Proprio per questo il ritrovarsi ogni fine settimana sui blocchi di Fontainebleau o sulle pareti di Saussois, è qualcosa di più di un semplice allenamento, ma è un modo di sentirsi uniti e di cementare amicizie fraterne.
Superata la Est del Grand Capucin, il grande problema del momento sul Monte Bianco era costituito dalla parete ovest del Petit Dru. Alta quasi 1000 metri, caratterizzata da gigantesche placche grigiastre lisce come il vetro, solo una decina d’anni prima era stata giudicata impossibile da quasi tutti gli alpinisti. Invece ora l’applicazione sistematica dell’arrampicata artificiale poteva anche mettere in condizione gli alpinisti di pensare seriamente alla sua salita. Ma su questa formidabile parete i problemi erano senz’altro superiori a quelli del Capucin. Innanzi tutto l’altezza della parete, più del doppio di quella del Capucin. Poi la fessurazione assai più larga, la quale avrebbe richiesto un larghissimo impiego di cunei di legno. Vi erano inoltre alcuni punti-chiave, che esaminati attentamente dal basso parevano assolutamente lisci ed insuperabili. I problemi logistici erano notevolissimi: la permanenza in parete per molti giorni rappresentava uno degli enigmi più importanti, soprattutto perché la mole di materiale da trasportare in parete sarebbe stata veramente notevole. E poi vi era il problema di un’eventuale ritirata, resa impossibile nella parte superiore della parete da alcuni enormi tetti sopra ai quali ci si sarebbe venuti a trovare.
Vi furono comunque tentativi: importante quello di Gilbert Vignes, che nel tratto inferiore della parete superò una durissima fessura in arrampicata libera, che ora appunto porta il suo nome. Ma il tentativo più serio ebbe luogo nei primi giorni di luglio (1-5) 1952, quando Lucien Bérardini, Guido Magnone e Adrien Dagory riuscirono a vincere più di metà parete, superando lunghi tratti in esclusiva arrampicata artificiale, come il muro di 40 metri, il tetto del «Bloc coincé» e soprattutto il famoso «diedro di 90 metri», forse il passaggio più impressionante e caratteristico di tutta la parete. L’uso dei chiodi e dei cunei si era rivelato assolutamente indispensabile, ma sopra il diedro di 90 metri, la stanchezza, la sete e una placca insuperabile li costrinsero alla ritirata.
Proseguire sarebbe stato possibile solo con un’ampia pendolata a destra su una immensa lastra inclinata, ma in tal modo essi si sarebbero tagliati ogni possibilità di ritirata, rischiando seriamente di perire per sfinimento. Due settimane dopo (17 luglio) essi sono nuovamente alla base del Dru, ma invece di ripercorrere la parte bassa della parete, per risparmiare tempo e fatica essi salgono lungo la via Allain della parete nord fino ad un terrazzino posto ad una quarantina di metri più in alto e a sinistra del punto massimo che essi avevano raggiunto sopra il diedro di 90 metri. Con una traversata assai problematica, ricorrendo anche all’uso di alcuni chiodi ad espansione piantati in una placca assolutamente levigata, Magnone, Bérardini, Dagory e Marcel Lainé riescono a portarsi al punto di fermata sopra il diedro. Poi compiono la pendolata, lasciando in loco una corda fissa per poter avere una ritirata sicura verso la parete nord in caso di abbandono.
Dopo un bivacco abbastanza tranquillo, i quattro, guidati da un Bérardini in splendida forma, raggiungono la vetta arrampicando sempre in libera e superando difficoltà un po’ inferiori a quelle che essi avevano previsto in quel tratto.
Come è facile immaginare, la salita fu criticata assai duramente dagli ambienti alpinistici internazionali, o meglio fu totalmente disapprovato il metodo di realizzazione ed i mezzi impiegati. In realtà si trattava di un’impresa di valore eccezionale, decisamente superiore al Capucin anche dal punto di vista psicologico. Secondo molti è stata la più importante e significativa scalata di roccia aperta sulle Alpi nel dopoguerra, in quanto dette origine ad una nuova concezione dell’alpinismo. D’altronde, la via fu poi ripetuta dagli stessi scalatori in un sol tratto dalla base fino alla vetta.
Ciò che comunque scandalizzò, fu innanzi tutto l’uso dei chiodi ad espansione e poi la rottura dei «sacri» canoni di unità di tempo e d’azione dell’impresa alpinistica. Più volte abbiamo detto che l’alpinismo fortunatamente non ha regole e quindi spiace che in certe occasioni alcuni insorgano a censori oppure a paladini, difendendo una legge che in realtà non esiste. Piuttosto si può esprimere un giudizio tra imprese differenti, ma non certo costringere gli alpinisti a seguire una certa linea. Eppure proprio questa legge invisibile è accettata e subita da tutti in silenzio e porta ad orribili schiavitù, quali quella di realizzare l’impresa ad ogni costo, vivere l’alpinismo solo in funzione dell’impresa stessa e della «performance», concepire la scalata solo come mezzo per raggiungere la vetta, che «deve» essere raggiunta e che rappresenta una meta ideale. Forse quando sapremo liberarci di queste inibizioni, finalmente scopriremo un nuovo rapporto con la montagna e finalmente potremo agire in assoluta libertà nel gioco personale, infischiandocene di valori etici e morali, di obblighi interiori e di pressioni esterne, di costrizioni che ci portano amaramente a dar prova della nostra forza, in un ciclo ripetitivo dove il dolore e l’insoddisfazione riportano sempre a ricominciare tutto daccapo.
Certo la schiavitù più triste è quella di dover sempre dimostrare agli altri ciò che si è fatto ed in che modo lo si è fatto. Ma quando si comincerà finalmente a capire che il giudizio altrui non vale nulla e che vale soltanto in quanto la nostra insicurezza ha bisogno di una conferma esterna? Fin quando gli alpinisti dovranno dichiarare di aver compiuto la tal via o la tal prima ascensione, fin quando una cordata si sentirà insoddisfatta perché dopo seicento metri di parete ha dovuto rinunciare a soli cento metri dalla vetta, fin quando non sarà spezzato il perfido incantesimo che porta a salire verso una vetta ideale, soffrendo ed espiando colpe che mai si sono commesse ma si è convinti di aver commesso, per poi ritornare delusi al piano e ricominciare tutto daccapo odiando se stessi ed i propri simili accusati di incomprensione, allora certo non vi sarà crescita alcuna ma soltanto come ciechi continueremo a girare nella grande arena del circo, suscitando i lazzi e le risa di un pubblico invisibile.
A suo modo anche Magnone fu un ribelle e lo fu coscientemente, se giunse ad affermare che «in ogni attività dell’uomo, chi cerca di creare qualcosa di nuovo che vada contro la tradizione vigente, deve aspettarsi una reazione di questo tipo».
Una cordata affiatatissima: Jean Couzy e René Desmaison
Le imprese compiute da Couzy (1923-1958) e Desmaison (1930-2007) seguono la prima salita della parete ovest del Dru e quindi, in un certo senso, si sono spinte sul piano tecnico e psicologico ancora più avanti.
Ambedue cittadini, Couzy e Desmaison si possono considerare tra i massimi esponenti dell’alpinismo del dopoguerra, al pari di un Bonatti, di un Buhl o di un Messner.
Caratteri assai diversi e personalità un po’ contrastanti non impedirono ai due di trovare un accordo quasi perfetto e di realizzare imprese di altissimo contenuto tecnico. Desmaison ha la tempra del lottatore indomito, tenace, irriducibile, anche polemico, dotato di qualità fisiche assolutamente al di fuori del comune. Couzy è invece assai freddo, analitico, calcolatore al massimo.
Desmaison è sempre stato l’uomo dell’azione pura e non si è mai perso in studi sui motivi dell’alpinismo ed in analisi sui suoi problemi. Couzy è forse stato la mente più acuta che l’alpinismo abbia avuto, o almeno una delle più aperte.
Per lui l’alpinismo non fu mai solo azione, anche se come alpinista era perfetto e completo su ogni terreno. Ciò che egli seppe dare all’alpinismo (non solo francese) è difficilmente calcolabile: famosi sono i suoi studi sulla valutazione delle difficoltà, studi che finalmente giunsero a far chiaro nella confusione creatasi tra Alpi Orientali e Alpi Occidentali, studi attraverso i quali si giunse alla formulazione di una scala che ancora oggi pare la più valida ed è universalmente accettata. Per anni fu redattore della rivista Alpinisme, organo del GHM e seppe dare alla pubblicazione un tono ed un respiro che non ha più raggiunto in seguito. Studiò appositamente tre lingue (inglese, italiano, tedesco) per poter seguire con scrupolo la cronaca alpinistica internazionale e per poter essere aggiornato sulla letteratura alpinistica degli altri Paesi e sui problemi che venivano discussi sulle altre pubblicazioni.
Fece anche studi sull’uso dell’ossigeno alle alte quote. Si è detto che fu mente aperta. Ed è vero. Sulla sua spinta l’alpinismo francese potrà portarsi a dei livelli di indiscussa supremazia, soprattutto nelle grandi spedizioni extraeuropee dirette alle catene asiatiche. Ingegnere aeronautico, personalità brillante anche nella vita, Couzy forse è uno dei pochi che siano riusciti ad armonizzare l’alpinismo con il contesto vitale, senza per questo sacrificare o ridurre altri interessi estranei al mondo della montagna.
Anche la cordata Couzy-Desmaison inizia con la ripetizione dei grandi itinerari dell’anteguerra. Ma poi è naturale che un uomo d’azione come Desmaison ed un istinto analitico e creativo come Couzy giungessero a tracciare nuovi itinerari di notevolissima classe, dove l’arditezza e la logica essenziale del tracciato si univano alla eccezionale difficoltà tecnica dei singoli passaggi superati.
Ed eccoli infatti (1956) vincere l’affilato spigolo nord dell’Aiguille Noire de Peutérey (non ancora ripetuto), la direttissima sulla parete ovest della Noire (1957, non ancora ripetuta) e soprattutto (1956) la parete nord-ovest del Pic d’Olan, il loro capolavoro, superata lungo un itinerario diretto che dai ripetitori di ieri e di oggi è valutato come una delle scalate più ardue delle Alpi, decisamente superiore alla via dei Francesi sulla parete ovest del Dru.
Da ricordare anche (1957) la prima invernale della stessa via dei francesi sul Petit Dru, impresa notevolissima, probabilmente la prima grande realizzazione di quella portata nel Gruppo del Monte Bianco.
Purtroppo la carriera di Couzy fu tragicamente troncata nel 1958 da un incidente occorsogli sulla Crête des Bergers, sulle Prealpi del Dévoluy, dove fu colpito da una scarica di sassi al capo. Proprio a seguito di questo incidente si cominciò ad introdurre l’uso del casco di protezione. Ma di Couzy bisogna ancora ricordare l’esplorazione metodica dei gruppi calcarei delle Prealpi Francesi (unitamente al marsigliese Georges Livanos ed al lionese Serge Coupé), che poi si riveleranno come un esteso e formidabile campo d’attività per l’arrampicata su roccia. Ancora le molte campagne dolomitiche, dove si assicurò la ripetizione di tutti i grandi itinerari aperti prima della guerra, facendo luce sui vari gradi di difficoltà e ridimensionando alcuni giudizi troppo affrettati. Desmaison invece ha proseguito la sua carriera sfolgorante e tutt’oggi (1) è uno degli alpinisti più quotati d’Europa, seppur non sia più giovanissimo (è nato nel 1930) (Desmaison è scomparso nel 2007, NdR). Al pari di un Bonatti egli si è imposto all’attenzione del grande pubblico con le sue realizzazioni stupefacenti. Al pari di un Bonatti, purtroppo, è stato duramente toccato dalla tragedia e anche in questo caso la stampa ha condotto il suo sporco gioco. Al pari di un Bonatti anch’egli è divenuto un professionista dell’alpinismo e di alpinismo vive, scrivendo libri, tenendo conferenze, prestando il suo nome al commercio e alla pubblicità. Dal punto di vista dell’attività alpinistica pura, Desmaison forse non ha rivali in tutta Europa.
Su ogni terreno ha aperto nuove vie di estrema difficoltà: roccia granitica, roccia calcarea, misto, ghiaccio, Ande Peruviane, Himalaya. E poi ancora prime invernali e prime solitarie che vanno inserite tra le più grandi realizzazioni alpinistiche del dopoguerra. Basti citare la prima solitaria della via Magnone sul Petit Dru, quella della via Brown sulla Aiguille de la Blaitière e quella più recente della cresta integrale di Peutérey. Tra le invernali ricordiamo imprese d’eccezione come quella della parete nord ovest del Pic d’Olan, del Linceul alle Grandes Jorasses e, certamente la sua più grande impresa, quella del Pilone Centrale del Fréney. Sicuramente quest’ultima impresa (1-6 febbraio 1967, con Robert Flematty) va ricordata come una delle più stupefacenti dimostrazioni di audacia e di preparazione psicofisica che l’alpinismo ci abbia mai dato. A parte le fortissime difficoltà tecniche che il pilastro offre già in estate, bisogna tener conto che in inverno la marcia d’approccio costituisce già di per sé una salita massacrante, soprattutto per il carico enorme dei sacchi. E poi l’isolamento contribuisce ancor più a rendere acuta la difficoltà psicologica, resa già di per sé angosciosa dal pensiero di un cambiamento del tempo, che potrebbe rendere impossibile una ritirata verso il basso come un’uscita verso l’alto. Ma ciò non stupisce parlando di Desmaison: la sua tenacia, la sua resistenza fisica e psichica, la sua determinazione sono note a tutti gli alpinisti che sempre hanno riconosciuto in lui il migliore alpinista di Francia degli anni Sessanta. Nel 1971, in inverno, fu protagonista di un tragico tentativo di aprire una nuova via diretta sulla parete nord della Punta Walker delle Grandes Jorasses. Ad un centinaio di metri dalla vetta, dopo molti giorni di durissima arrampicata, fu bloccato dal maltempo con il suo giovane compagno Serge Gouseault. I due resistettero ancora per alcuni giorni, nella vana attesa del salvataggio che avrebbe dovuto giungere attraverso un elicottero. Ma per un motivo o per l’altro (ne sorse una polemica molto amara tra lo stesso Desmaison, il quale non era in buoni rapporti con gli ambienti locali di Chamonix a causa di un salvataggio effettuato sul Dru, e le guide di Chamonix), i salvataggi vennero rimandati, soprattutto a causa delle pessime condizioni atmosferiche, che non permettevano il posarsi dell’elicottero. Purtroppo Gousseault si spense per sfinimento, dopo una penosa agonia. Desmaison, privo di viveri, privo di gas e quindi impossibilitato a procurarsi bevande e acqua, seppe ancora resistere per qualche giorno, dimostrando di possedere una tempra ed una forza interiore che sfuggono al normale metro di misurazione delle possibilità umane. Infine, quando ormai si era certi della sua morte, fu tratto in salvo per mezzo dell’elicottero e con l’aiuto di alcune guide di Courmayeur e di Chamonix. Sconcerta il fatto che egli da questa storia allucinante, almeno fisicamente ne uscì pressoché indenne. Comunque, due anni dopo, nell’inverno 1973, Desmaison ritorna sulla stessa parete e, con il forte alpinista e guida alpina italiana Giorgio Bertone e con Michel Claret, porta a termine la via che nel 1971 aveva tentato con lo sfortunato Gousseault.
Amante della scalata pura, sulle Prealpi Francesi ha aperto un numero impressionante di vie estremamente difficili e complesse. D’altronde il suo capolavoro d’arrampicata resta pur sempre la via aperta sugli strapiombi della parete nord della Ovest di Lavaredo, di cui parleremo nella trattazione riservata alle Dolomiti.
In questo periodo ed andando oltre fino ai giorni nostri, riesce sempre più difficile isolare fatti e personaggi e cercare tra le mille imprese di valore quelle più significative. Più che altro si possono individuare dei gruppi riuniti da un certo intento nel pensiero e nell’azione, che li differenzia da altri gruppi di tendenza più avanzata in seno all’applicazione dei mezzi artificiali. Se ci riferiamo a Bonatti, possiamo sicuramente dire che egli fu un conservatore, nel senso che si è sempre battuto contro il chiodo ad espansione e contro la tecnica di progressione americana, che si serve di installazione di corde fisse e di assalti successivi. Comunque anche Bonatti ha fatto largo uso di mezzi artificiali, ma solo dove questi erano assolutamente necessari.
Un Desmaison si dimostra già più aperto verso l’artificialismo, anche se le sue imprese sono veri modelli di stile classico ed alpino. Egli ha impiegato varie volte i chiodi ad espansione, ma più che altro soltanto per vincere alcuni tratti isolati dove era impossibile chiodare normalmente. Mai si è dedicato all’apertura di una via da superare integralmente con chiodi ad espansione. E poi, anche a detta dei ripetitori delle sue vie, Desmaison prima di forare la roccia, ha sempre cercato ogni mezzo «normale» per cercare di passare, ricorrendo ad acrobazie veramente raffinate ed un po’ allucinanti. Come più volte si è detto, è interessante osservare l’inibizione fortissima a forare la roccia presente negli ambienti alpinistici europei. Vedremo come in America e soprattutto in California, forse per la mancanza di un’eredità culturale derivata da cent’anni di storia alpinistica europea, questa inibizione inizialmente fosse pressoché assente. Sarà poi il contatto con gli ambienti alpinistici europei a inculcarla anche nei californiani e a trasmettere nella loro ideologia il concetto di purismo, che proprio qui verrà poi radicalizzato e portato a vertici che neanche in Europa sono stati raggiunti…!
Comunque, accanto ad un Desmaison, in questo periodo in Francia sono molti gli alpinisti di valore che realizzano imprese di prestigio. Dobbiamo ricordare soprattutto la guida di Chamonix André Contamine, autore di splendide salite, come la parete ovest delle Petites Jorasses, certamente uno degli itinerari più difficili ed eleganti del Monte Bianco, notevole dal punto di vista estetico, in quanto fu realizzato pressoché in arrampicata libera con scarsissimo impiego di chiodi. Dobbiamo ricordare Michel Bastien, Pierre Julien, Pierre Mazeaud, Pierre Kohlmann, alpinisti di classe indiscussa, che precedono i fortissimi esponenti dell’ultimissima generazione: Yannick Seigneur, Patrick Cordier, Jean-Claude Droyer, François Guillot, Joël Coquegniot, Claude Jager, Jean-Claude Mosca, Jean-Claude Marmier, Bernard Mellet, ragazzi capaci di imprese mozzafiato.
Nota
(1) Nella seconda metà degli anni Settanta.
Scopri di più da GognaBlog
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.



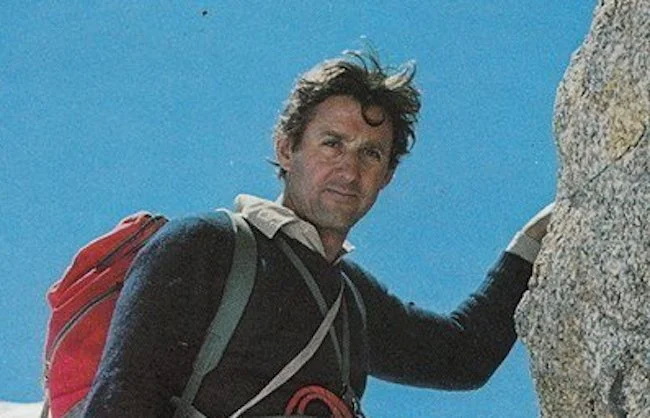
Mi sono anch’io dispiaciuta che sia un fatto comunemente accettato.
…. e anche in questo caso la stampa ha condotto il suo sporco gioco.
Mannò!?
Vengono signori, vengono…